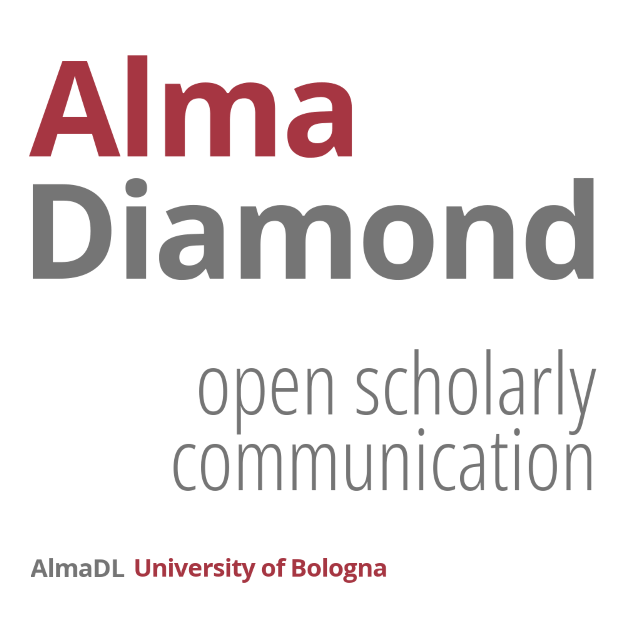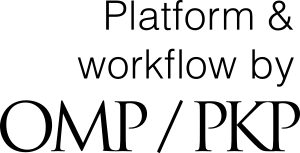Il respiro del movimento - About
Focus and Scope
The series publishes scientific essays on theatre studies, with a particular focus on dance, as well as theatre in the strict sense, music and performing arts such as puppetry, circus and musical theatre. The approach may be historiographical, philological, aesthetic or anthropological. The series includes unpublished works, as well as updated re-editions of previously published books and translations of texts from foreign languages. The volumes are intended for scholars and specialists in the arts concerned.
Series Roles
Scientific Editors
-
Elena Cervellati, Alma Mater Studiorum Università di Bologna (IT)
https://orcid.org/0000-0002-8038-001X -
Elena Randi, Alma Mater Studiorum Università di Bologna (IT)
https://orcid.org/0000-0002-0342-0428
Scientific Board
-
Sonia Bellavia, La Sapienza Università di Roma (IT)
-
Matilda Butkas Ertz, University of Louisville, KY (US)
-
María del Valle de Moya Martinez, Universidad de Castilla-La Mancha (ES)
-
Doug Fullington, Pacific Northwest Ballet, WA (US)
-
Teresa Megale, Università di Firenze (IT)
-
Stefania Onesti, Università di Siena (IT)
-
Giulia Taddeo, Università di Genova (IT)
-
Lester Tomé, Smith College, Northampton, MA (US)
Peer Review Process
The series submits books to a non-anonymous peer review process (open peer review) in which the identities of authors and reviewers are known to each other.
Reviewers are internal to the series.
Peer review takes place during the pre-publication phase under the responsibility of the Scientific Editors of the series.
For further information, see the service policies.
Open Access Policy
The series follows an open access policy in all its contents, in order to facilitate as much as possible the diffusion of scientific knowledge among scholars and all interested people.
It releases its books under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).
The authors who publish in this series retain copyright.
For further information see the service Open Access Policy
Submissions
When submitting a proposal, authors must verify that the following requirements are met:
- The proposed text has not been previously published by another publisher (or special arrangements have been made with the previous publisher and the series editors, and a written explanation of these arrangements is provided);
- The submission file is in Microsoft Word format;
- The text strictly follows the editorial guidelines for the series, as indicated below;
- The author of the book provides copyright and reproduction release forms for all images.
- Proposals may be rejected if they do not comply with these requirements.
Author Guidelines
Editorial Guidelines
Text
- The text should be between 25.000 and 60.000 characters including spaces.
- The text should be in Word or RTF format, the font should be Times New Roman 12 for the text, 10 for the notes, paragraph 1,5, margins 3 cm.
- Within the text, the work titles and foreign words, if not of common use, should be in italics.
Quotations
- When less than three lines use directional double quotation marks («») and capitalize the first word.
- When more than three lines: use font size 11, with any quotation marks, leaving a blank line before and one after the quote.
- Use double quotation marks when you have a quotation within quotation.
- Quotations from languages other than the prevailing language of the essay must be translated into the language of the essay, they may possibly be reported in the original in a note.
Footnotes
- Footnotes should be font size 10, at the bottom of the page and will appear in the text of the paper as a superscript number, eg ¹ and will be positioned before any punctuation marks (but will have to follow the exclamation mark, the question mark, brackets, quotation marks).
Quotation marks
- Directional double quotation marks («») should be used for: quotations less than three lines, newspapers, magazines and academic journals.
- Double quotation marks (““) should be used for: quotation within quotation, words or phrases which need an emphasis.
Images
- Any images should be included in the text, not at the end, to indicate the position in which the author wishes to place them. They must be accompanied by a caption in block 10 opened by the label “Figure”, followed by the progressive number of the image; the caption will give as complete information as possible on the source and the author.
- The images must be sent separately, in a resolution of no less than 300 dpi.
- Each image file must be numbered progressively, corresponding to the numbering indicated in the text.
- In the body of the text, any references to images will be indicated by “fig.”.
Bibliographic citations
Volumes
- Author’s Name
- Author’s Surname,
- Title,
- Place of Publication,
- Name of Publisher
- Date of Publication,
- p. or pp. [where the citation can be found]
Exempla:
- Walter Sorell, Storia della danza. Arte, cultura, società, Il Mulino, Bologna 1994, pp. 22-23.
- Claude Aveline – Michel Dufet, Bourdelle et la danse. Isadora et Nijinsky, Arted, Paris 1969.
Translated works
-
Cite the original work, adding the English version.
Ex.: Pierre Biner, Le Living Theatre: histoire sans légende, La Cité, Lausanne 1968 (transl: The Living Theatre, Horizon, New York 1972).
-
If you are referencing a citation from the English translation, add in parenthesis the main elements of the original version.
Ex.: Pierre Biner, The Living Theatre, Horizon, New York 1972 (orig. ed. Le Living Theatre, La Cité, Lausanne 1968).
Miscellanea Contributes or Conference Proceedings
- Author’s Name
- Author’s Surname,
- Title [of the contribute],
- in Name(s) Surname(s) of the editors [care of] (edited by),
- Title [of the volume],
- Name of Publisher,
- Place of Publication
- Date of Publication,
- pp. [where the contribute is included]: p. [or pp. where the citation can be found].
Ex.: Norbert Servos, Pina Bausch: dance and emancipation, in Angela Carter (edited by), The Routledge dance studies reader, Routledge, London-New York 1998, pp. 36-45: p. 39.
Entries in Dictionary or Encyclopaedia
- Author’s Name,
- Author’s Surname [when it is possible],
- entry in italics [for ex. pantomime],
- in Title [of the Encyclopaedia or Dictionary],
- edited by [curator’s full name],
- Name of Publisher,
- Place of Publication,
- Date of Publication,
- ad vocem
- vol. [roman numeral]
- p. or pp. [where the entry is included]
It is the author’s choice to indicate the overall number of volumes (e.g. 12 voll.,) followed by a comma and placed after the publication date of the work. Any choice must be consistent because a uniform criterion must be followed.
Ex.: Gerhard Kroll, Angiolini Gasparo, in The New Grove Dictionary of Music and Musicians, edited by Stanley Sadie, Macmillan, London, 2001, 29 voll., ad vocem, vol. I, pp. 425-426.
Article in a journal
- Author’s Name
- Author’s Surname,
- Title [of the article],
- in «Title» [of the journal],
- [if any title of the special issue],
- edited by Name(s) Surname(s) of the editors,
- n. [followed by journal number in Arabic numerals],
- Date of Publication [in full],
- pp. [where the article can be found]: p. [or pp. where the citation can be found]
Exempla:
- Roland Barthes, Introduction à l’analyse structurale des récits, in «Communications», n. 8, 1966, pp. 7-33: p. 16.
- André Lepecki, The Body as Archive, in «Dance Research Journal», special issue Dance in the museum, edited by Mark Franko and André Lepecki, n. 3, December 2014, pp. 29-48.
- Matthias Herrmann – Marie Glon, Présenter la danse aux enfants, in «Repères, cahier de danse», numéro monographique Enfants. Quels projets pour l’enfance dans la danse?, vol. XXXVI, n. 2, 2015, pp. 29-31.
Newspaper article
- Author’s Name
- Author’s Surname,
- Title [of the article],
- in «Title» [of the newspaper],
- Date of Publication [in full]
Ex.: Emily Kent Smith and Tony Allen-Mills, Ballet dancers in lockdown hear patter of tiny feet, in «The Sunday Times», Sunday January 10, 2021.
Degree or Doctoral Thesis
- Name
- Surname
- Title,
- degree or doctoral programme,
- University
- date,
- thesis advisor [if applicable],
- p. o pp.
Exempla:
- Claudia Zampieri, Il ballo teatrale a Bologna fra Settecento e Ottocento, tesi di laurea, Università degli studi di Bologna 1987-88, relatore prof. Lorenzo Bianconi.
- Kathleen Kuzmick Hansell, Opera and ballet at the Regio Ducal Teatro of Milan, 1771-1776: a musical and social history, Ph.D., University of California, Berkeley 1980.
Electronic sources
- If the cited work is published only or also in electronic format, then at the end of the reference it should be added the web address where the article can be accessed, preceeded by “online:” and followed by the date of the last access in parenthesis “(u.v.: [full date])”
Exempla:
- Carlo Titomanlio, Cronache del mondo fluttuante. Il teatro kabuki nei racconti di Ihara Saikaku, in «Antropologia e teatro», n. 5, 2014, pp. 70-86, online: http://antropologiaeteatro.unibo.it (u.v. 15/1/2017).
- John Whitehead, Matthew Bourne’s Swan Lake. Resources for teachers and students, 2013, online: https://new-adventures.net/media/files/education-packs/1362_1_SwanLake_resource_pack_small.pdf (u.v. 15/1/2017).
Website content
- Indicate the website address preceded by “online:” and followed by access date as the example below.
Ex.: Marius Petipa Society, online: https://petipasociety.com/ (u.v. 7/11/2019).
Reference to cited work
- Author’s Name
- Author’s Surname,
- Title [of the book or of the article, abbreviated when particularly long, with no suspension dots]
- cit.,
- p. [o pp.].
Ex.: Walter Sorell, Storia della danza, cit., p. 150.
If necessary, use:
- Ibidem [bibliographic reference similar to the once cited above]
- Ivi, p. [bibliographic reference similar to the once cited in the previous note, different page]
Other indications
-
Chapter titles, poems, other parts of the book: in italics
Ex.: Foreword
-
Titles within other titles: italics with double quotation marks
Ex.: L’esthétique des “Fleurs du mal” et son influence
-
Texts included in a volume by the same author
Ex.: Roland Barthes, Une société sans romans, in Id., Œuvres complètes, sous la direction de Eric Marty, Seuil, Paris 2002, vol. II, pp. 208-223.
Use “Id.” only when you are indicating an author’s essay within the work of the same author. Always use “Id.,” even when the author is a woman (not “Ead.”.)
-
Use roman for terms in foreign language which are of common use:
butoh, judo, yoga, status, ad hoc, silhouette, troupe, in primis, cliché, trance, iter, chiffon, roulette, collage.
Use always a lowercase initial unless they follow a full stop.Capital letters are put exactly as they are in the title page.
Frequently used abbreviations
- See [compare]
- p., pp. [page, pages]
- [sic] [italics, no exclamation mark]
- s.n. [no place of publication]
- Anonymous [when the author is unknown]
- ss. [following pages]
- vol., voll. [volume, volumes]
- t. [tome]